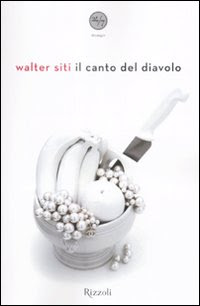 Premetto: sono eterosessuale. Ho sempre amato le donne, da quando mi sono accorto che esistevano, o meglio da quando loro si sono accorte che esistevo io. Avevo quattordici anni e tre mesi e dovevo già radermi ed ero solo pochi centimetri meno di adesso, un gigante spaesato che i compagni di classe chiamavano il vichingo, sradicato dal suo tutto, e lei di anni ne aveva trentacinque, ed era amica di mia madre, si chiamava Susanna, un nome da formaggino, gli occhi scuri e i capelli tinti di un biondo che mi ricordava casa.
Premetto: sono eterosessuale. Ho sempre amato le donne, da quando mi sono accorto che esistevano, o meglio da quando loro si sono accorte che esistevo io. Avevo quattordici anni e tre mesi e dovevo già radermi ed ero solo pochi centimetri meno di adesso, un gigante spaesato che i compagni di classe chiamavano il vichingo, sradicato dal suo tutto, e lei di anni ne aveva trentacinque, ed era amica di mia madre, si chiamava Susanna, un nome da formaggino, gli occhi scuri e i capelli tinti di un biondo che mi ricordava casa.Mi offrì il primo bacio e la prima sigaretta, una multifilter blu, e mi regalò un quaderno che curasse la nostalgia. Mi faceva piangere e pensare che ammazzarmi fosse l’unica via di fuga che mi restava: quando vorresti morire scrivi, mi disse, puoi farlo in tedesco, e sarà come tornare.
La ringraziai senza crederle: c’è voluta una vita per imparare quanto avesse ragione.
Non l’amavo, perché non ero capace: odiavo tutto, e soprattutto me. Quando cambiammo casa e la persi di vista non feci niente per ritrovarla. Da allora – sono passati più di vent’anni - non ne so più nulla, e mi dispiace, adesso, che lei è uno dei pochi ricordi belli che mi restano, e altre donne –in realtà, soltanto una– mi hanno reso quello che sono. Ma comunque sia – anche adesso, anche così – continuo a credere che un uomo senza una donna non possa avere senso: anche quando ti uccidono, sono la causa prima per cui siamo. L’anello di congiunzione tra l’uomo e dio, o il demonio, che è la stessa cosa, all’altro estremo della scala: in un caso e nell’altro sono loro a portarci in cima o in fondo, loro che ci spingono sulla strada, e che sia quella giusta o quella sbagliata non conta, senza di loro resteremmo immobili, sul ciglio, senza un pretesto per scegliere, e sarebbe infinitamente peggio - peggio anche di questo - non esistere, mai.
Premetto ancora: non ho mai pensato che l’identità sessuale potesse essere liquida, per quanto mi riguarda, almeno. Io sono un uomo, e amo le donne. Punto. Non mi riesce di immaginare qualcosa di diverso, la mia parte femminile è stata la mia donna, e prima di lei mia madre, e adesso, che è successo quello che è successo, mia sorella, con cui divido la casa e tante sere nere, i suoi numeri e le mie parole, la sua motocicletta e la mia motrice, due modi opposti di cercare risposte che miracolosamente completano il puzzle, perché è vero che sono l’altra metà del cielo, sono figlio dell’androgino io, spaccato a metà dal fulmine nel simposio, e cerco la metà amputata che mi manca.
È questa la ragione per cui ci ho messo tanto, a leggere le 205 pagine di questo libro, dalla dedica ai ringraziamenti inclusi: il perché ci ho messo tanto e il perché l’ho capito solo in parte, anche, e questo è un peccato, perché è indiscutibilmente un bel libro, che intessuta in un’ottima guida lonely planet post Naomi Klein sugli Emirati porta una storia d’amore scritta con gli occhi feriti a morte di chi l’amore ha avuto il coraggio di guardarlo in faccia, e sì che ci vuole coraggio ad essere “l’altro”, non si ha niente e non si può chiedere niente, nemmeno di essere amati, perché significherebbe imporre una scelta, e il rischio che significhi la fine anche di quel niente cui si sta aggrappati è fuori questione, e così pazienza se si viene maciullati ogni attimo, ne sa qualcosa il mio amico Giuseppe, che è stato l’amante per anni, e, dio, quant’è bella questa parola, e quanto è tremenda se non si associa a nient’altro, quant’è straziante quando significa solo niente domeniche e niente natale e niente compleanni, solo ristoranti sul mare d’inverno e qualche weekend camuffato da lavoro, guai se lo scopre qualcuno.
È una storia che gronda vita – nel senso letterale: qui e là sgranata, come la vita è, una montagna russa in cui basta un cellulare irraggiungibile a spegnere le luci sul mondo - ed è raccontata bene, in una lingua zeppa di riferimenti quanto più cerca di destrutturarsi nel gergo, sudore di uno scrittore vero, cui riesce senza sforzo quello che chiunque provi a scrivere sogna, fare buio in sala e proiettarti ogni riga nel cervello, finchè non sei lì, nel bel mezzo della pagina che ti viene incontro e senti, finalmente, il profumo dei gladioli e le grida dei russi che giocano a pallavolo in piscina e tutto il resto, anche il sapore del risotto con asparagi e tartufi, e sopra ogni cosa il dolore dell’amore che non riesce a ritagliarsi una stanza tutta per sé nella vita di ogni giorno, che è confinato alla vacanza, al ritaglio, nessuna certezza del domani.
Tutto chiarissimo, so cosa sia, cercare di comprare quello che può essere solo un regalo,io che nel 2000 avevo 35 milioni di debiti (e ci tengo a sottolineare che proprio allora tornammo assieme, quando non potevo offrirti nient’altro che me, a riprova che ci sono cose che non hanno prezzo, né possono averlo, e com’è andata a finire è un’altra storia).
Ma questo libro è una lettera d’amore – sussurrata nelle prime pagine, a voce così bassa che ti chiedi se hai capito bene, così rileggi, finché non ti rassegni – e poi urlata – senza nessuna forma di discreta censura, e sì che Lui è sposato, e cerca ai bazar un posacenere da regalare alla moglie – per Massimo e il suo lessico romanesco e il suo perizoma da culturista, cui lo scrittore regala una vacanza superlusso per ricompensarlo di esistere, prima di immergersi in un viaggio solitario e necessariamente low cost oltre l’ologramma di una terra fabbricata con il Lego, alla ricerca della sua anima e della propria, entrambe perse, l’una soffocata dalla plastica di sogni faraonici e l’altra dal suo amore clandestino.
E purtroppo, malgrado i trentasette anni e i forse trentasettemilioni di chilometri che ho alle spalle, l’unico modo che ho avuto di decodificarlo è stato trasformare Massimo in Marina, farne un adattamento che mi fosse comprensibile, e necessariamente questo ha significato semplificare, distorcere, e molta parte del tutto mi è rimasta oscura.
Me ne scuso, non è rifiuto del diverso, no, è una vita che sono diverso in quasi tutto, sono mancino, e zero negativo, e porto il 47 di scarpe e ho capelli e ciglia così chiari che sembrano bianchi, ma ci sono cose che vanno oltre quello che posso capire, che hanno strutture e meccanismi che mi sfuggono, e quando succede devo trasformarne l’algoritmo in un simbolismo che mi sia comprensibile, e il risultato necessario è perderne le (probabilmente più profonde) sfumature.
Come questa volta, ed è stato un peccato: di questo libro – gli Emirati restano sullo sfondo – mi è rimasta la sensazione sgradevole del disegno del tappeto impresso sulle ginocchia di Massimo a pag. 34, che è stata un pugno nello stomaco, non mi vergogno a dirlo, per me come per molti uomini (la maggior parte? Questo non lo so. Sono uno solo, io.)
Peccato, davvero. Una storia bellissima, raccontata ancora meglio. Ma sarebbe stato troppo sforzo chiamare Massimo Marina? Troppo sforzo concederci di capire, davvero? Ho trentasette anni e trentasettemilioni di chilometri alle spalle. E chiuso il libro è alla moglie di Massimo, che penso, al suo sorriso quando avrà ricevuto il posacenere, al dolore che non sa di provare, perché, ne sono certo, lei non sa.
Ma poi finalmente capisco, è questo il miracolo vero di un vero libro, la moglie di Massimo nella storia non c’è, non si vede, eppure io l’ho vista, sto pensando a quello che deve aver pensato, sono entrato nei suoi panni, e magari lei nemmeno esiste, è tutto inventato, ma io la vedo, questa donna che è rimasta a Roma, che ha aspettato che il marito tornasse ed è corsa a prenderlo all’aeroporto, il suo muscoloso marito che neanche saprebbe immaginare carponi sul tappeto del resort che le ha portato in regalo il patchouli e chissà cos’altro comprato nei suk che visitava con il suo amante di sessantadue anni, chissà le balle che le ha raccontato per coprire tutto, e vorrei gridarlo, dirglielo, e prendere lui per il collo, anche, so cosa vuol dire essere traditi, e non credo che il dolore che si prova sia in relazione con chi.
Così, finalmente capisco, istintivamente ho scelto da che parte stare, sono entrato nella storia, ed è questo che conta. Che molto, moltissimo mi sfugga dei meccanismi di cui parla non è più importante, il fatto è che ci sono entrato, e questo è tutto.
È questo il miracolo vero di un vero libro.
E questo è un vero libro.
Avrei preferito che Massimo fosse Marina, sì.
Sarebbe stato più facile leggerlo. Ma è un vero libro, e il resto, gli Emirati, il perizoma e il tappeto, sono dettagli. Non conta di quali io – lettore, maschio, trentasettenne, eterosessuale, camionista, italotedesco - avrei volentieri fatto a meno.
AVREI PREFERITO MARINA ...
(WALTER SITI, IL CANTO DEL DIAVOLO, 2009, RIZZOLI MILANO, COLLANA 24sette)






